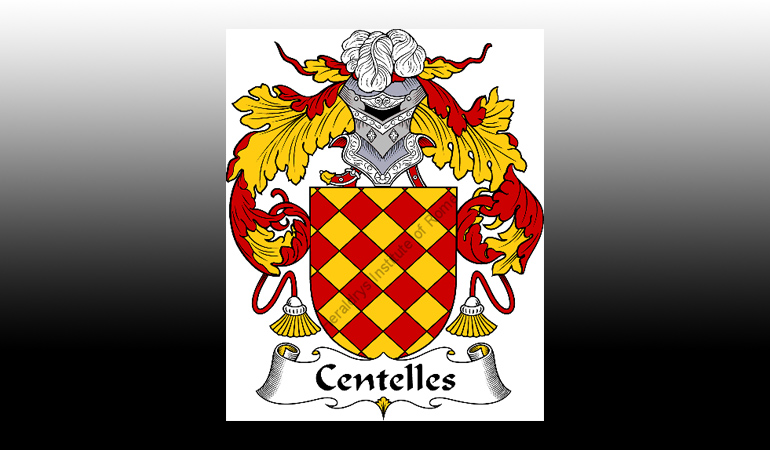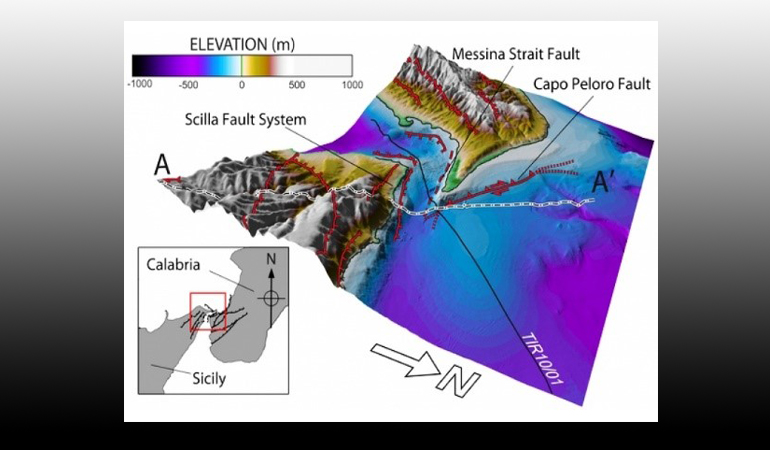Il matrimonio tra ritualità e sacralità sicuramente un tempo ricopriva un evento, per tradizione, certamente importante nella vita sociale di ogni famiglia, tanto per la donna quanto per l’uomo. Leggendo le schede di restituzione abbiamo veramente avuto la possibilità di cogliere la sua importanza tanto sotto il valore umano quanto sotto il valore sociale e morale.
Vogliamo riportare una testimonianza proprio di una delle tante schede di restituzione, tutte simili nel racconto, che ben documenta tale rito partendo dalla fase del fidanzamento, alquanto singolare per la tradizione di noi che viviamo “altri” tempi: “Un giorno mentre mi recavo a prendere ‘na bumbula d’acqua o casellu, mi incrociò per la prima volta un simpatico giovanotto anche lui diretto al pozzo del casello. Un personaggio misterioso, strano ma che nei giorni e nei periodi a seguire, rividi sempre più spesso quando uscivo di casa (quasi sempre accompagnata da mia sorella Maria, più grande di me di circa 4 anni).
Una presenza quella di questo giovane, che stava diventando sempre più costante nella mia vita; infatti, un bel giorno, me lo ritrovai anche a casa di cummari Maria ‘a maistra, dalla quale mi recavo alcuni pomeriggi della settimana per imparare a cucire. Nei giorni a seguire, questo baldo giovanotto lo vidi anche la domenica a messa e poi ancora anche quando mi recavo insieme ad alcuni miei familiari ‘o Livitu per raccogliere le olive.
La curiosità dentro di me cresceva sempre di più anche se avevo intuito che quel giovane tanto misterioso ma anche a mio avviso affascinante col suo modo di fare sempre modesto aveva, forse, qualche interesse verso la mia persona.
E infatti era proprio così! Non passò nemmeno un mese che cumpari Natu, marito di cummari Maria, una sera, venne a casa a trovarci chiedendo di mio padre”.
La figura di ‘mpari Natu a livello sociale, ricopre il ruolo detto di “sensali” o “tramezzaturi” ed è quella personalità particolare che gestisce l’eventuale fidanzamento dei due giovani mediando e facendosi garante tra le famiglie.
“Mio padre e cumpari Nato si sedettero in cucina e davanti a un buon bicchiere di vino di nostra produzione, comunicò a mio padre e a mia madre che c’era un ragazzo interessato a chiedere la mia mano. Mia madre mi chiese subito se avevo visto quel giovane mio spasimante e in quale occasione e io riferì quanto accaduto nelle settimane precedenti. Mio padre ovviamente chiese subito chi fosse il giovane e dopo avere discusso con cumpari Nato e dopo avere preso informazioni sulla famiglia, acconsentì al fidanzamento e tramite lo stesso cumpari Nato comunicò alla famiglia di voler ricevere a casa questo giovane. Io mi sentivo frastornata ma allo stesso tempo contenta perché a me in fondo, quel giovane piaceva.
La notizia ufficiale del mio fidanzamento venne resa nota ai miei parenti nel corso delle festività pasquali per le quali regalai al mio futuro marito ‘nu cuddhuraci’ rigorosamente a forma di cuore con venti uova.”
Chiara è a livello, socio-antropologico la valenza del dolce tipico con la sua forma a cuore e con le venti uova; numero preciso che indicava la fertilità, la fortuna e la lunga durata del matrimonio. Qualche scheda riportava anche la tradizione del tipico cuddhuraci a forma di cuore con un unico uovo posizionato al centro, la cosiddetta pancia del dolce, paragonata dunque al simbolo della fertilità e della maternità e che quindi nell’immaginario collettivo, simboleggiava la fertilità della futura sposa.
“Il mio fidanzato ovviamente incominciò a frequentare casa mia ma con visite limitate e assolutamente preventivate prima e a tal compito mio padre aveva incaricato mio fratello Micu. Rigide erano le regole alle quali dovevamo attenerci: noi durante la cena o il pranzo non potevamo sederci vicini (infatti lui si sedeva accanto a mio padre e attorniato dai miei tre fratelli) e i nostri sguardi non si potevano minimamente incrociare. Nel momento in cui mio padre decideva che era giunto il momento che lui doveva lasciare la nostra casa, lo faceva capire con una battuta e lui, molto rispettosamente, salutava e se ne andava.
Mia madre con le mie sorelle più grandi, già sposate, cominciò quindi, a sacrifici, a preparare in vista del matrimonio, la mia biancheria e la famosa dote iniziata già da fanciulla seguendo il famoso proverbio: Figghia fimmina ‘nta fascia, doti ‘nta cascia! Ricordo che la riponevano con grande cura e dedizione in una cassa di legno (a cascia).
Nei giorni precedenti le nozze, avvenne, alla presenza di alcuni parenti, il classico rito della stima di quanto io portavo in dote: dopo aver aperto la cassa, alcuni si occupavano di prelevare i pezzi del corredo e di riporli con cura su di una coperta ben distesa a terra, altri si occupavano di redigere la cosiddetta “minuta”, cioè l’elenco dei pezzi del corredo, il tutto in carta debitamente bollata con tanto di testimoni e timbro notarile. Linzola, cutri, tuvagghi pa buffetta, tuvagghi pa facci, matarazzi i scarfogghi e crinu, vantali, muccaturi, na pettinissa pi capiddhi, nu paru i cuscina chi fodiri i tila erano alcune delle cose che facevano parte della mia dote.
Concluso questo rito della stima, si avviava il rito della “cunsigna”: sistemata ordinatamente tutta la mia dote nella coperta sulla quale era stata adagiata e richiusa quest’ultima similmente a un fagotto detto truscia, partiva un festoso corteo che portava il tutto nella mia futura casa nuziale.
Una volta giunti, si apriva la truscia e il tutto veniva sistemato in un baule con certosina pazienza dalla madre della sposa e dalla suocera, il cosiddetto “baullu” (a tale rito la futura sposa però non poteva assistere). Due giorni prima delle nozze avvenne la preparazione del letto matrimoniale e sempre per tradizione che imponeva la preparazione fatta da due persone (una per la parte dello sposo e una per la parte della sposa), una mia zia materna e una zia del mio futuro sposo alla presenza di tutti i parenti, sistemarono il mio letto matrimoniale e sempre seguendo la tradizione del tempo, tutti i parenti iniziarono a gettare soldi sul letto in segno di fortuna e benessere.
Finalmente giunse il tanto atteso giorno delle nozze: il 3 Giugno 1946. Di buon mattino ci alzammo e mia madre con le mie sorelle iniziarono, molto celermente, a dare una risistemata alla casa in vista dell’arrivo degli invitati.
All’orario prestabilito indossai, con l’aiuto delle mie sorelle e di mia madre, il mio abito bianco, sistemai i miei capelli a tuppo e quando giunsero tutti gli invitati avvenne un altro rito molto significativo che segnò il distacco dalla mia famiglia e il saluto a quella che era stata la mia casa familiare: sull’uscio di casa, inginocchiata, ricevetti la benedizione di mio padre e di mia madre per essere diventata sposa.
Arrivato quindi lo sposo con i suoi invitati, partimmo in corteo diretti in chiesa per maritarmi. Nel corteo io diedi il braccio a mio padre e il mio sposo alla madre, seguivano tutte le coppie di invitati di riguardo come i compari d’anello e i testimoni e poi tutti gli altri invitati.
Io mi sposai nella chiesa di S. Maria delle Grazie a Lazzaro e ricordo quel giorno come fosse ieri; una cerimonia molto sobria, sentita e allo stesso tempo emozionante.
Finita la cerimonia religiosa, all’uscita dalla chiesa fummo festeggiati con il tradizionale lancio di confetti e di monetine. Immediatamente, in corteo stavolta aperto da me e mio marito che ci tenevamo a braccetto, partimmo diretti verso la casa dei miei suoceri dove si tennero i festeggiamenti.
Giunti nella casa dei miei suoceri, mi cambiai subito d’abito, svestì l’abito bianco della cerimonia e indossai un abito nero.
Particolarmente significativo risulta essere questo passaggio del cambio d’abito da colore bianco a colore nero che tende proprio a indicare a livello antropologico-culturale, la perdita simbolica del candore e della purezza della sposa.
“Ebbe così inizio il pranzo in onore degli sposi che prevedeva un menù a base di pasta del tipo ‘i zziti condita con sugo di pomodoro e come secondo piatto ci fu della carne, seguivano poi i confetti e i dolci preparati in casa e il tutto accompagnato da organetto e tamburello al ritmo di tarantella fino a tarda serata e fin quando giunsimo nella nostra nuova casa coniugale.
Arrivati sull’uscio della nuova abitazione, sempre accompagnati da parenti e amici, ricevemmo, in qualità di neosposi una nuova benedizione:<<o mamma benedicitinci lu latti, o patri benedicitile che è notti!>>.
La prima notte di nozze la trascorremmo a casa; al mattino seguente mia suocera ci portò la colazione e io dovetti mostrargli il lenzuolo che avrebbe constatato la mia verginità prematrimoniale.
Nei giorni a seguire, come la tradizione del tempo voleva, fummo chiusi in casa: solo mia suocera e mio padre venivano a portarci da mangiare; potevamo solo ricevere le visite degli amici che in effetti non mancarono. Ricevemmo come regali da visita: uova, qualche gallina da brodo, zucchero e caffè. Solo all’ottavo giorno potemmo uscire. Infatti indossai l’abito nero e con mio marito andammo a Reggio per farci le foto.
Nelle settimane successive in molti vennero a farci visita e a tutti io facevo vedere la nostra umile casa, arredata con pochi mobili fatti da falegnami locali che io e mio marito avevamo portato in dote. La nostra casa era costituita da due stanze divise da una tenda di mezzo per delimitare la zona giorno e la zona notte. Nella prima stanza c’era la cucina, un tavolo detto ‘buffetta, quattro sedie di legno e paglia, ‘na cascia, ‘na maidda per impastare, ‘na pignata e ‘na tiella, ‘na giarra pi l’ogghiu, ‘nu salaturi, ‘na bumbula pi l’acqua, ‘na cristallera.
Nella seconda stanza avevamo sistemato il letto matrimoniale fatto con due trispiti di ferro sui quali vi erano appoggiate delle tavole che sorreggevano i materassi riempiti con crinu e scarfogghi e ai lati del letto vi erano anche due comodini o colonnetti realizzati da cumpari Santu u falignami. Poi c’era ‘u comò, sul quale avevo sistemato ‘nu lavamanu cu l’acqua, un piccolo baule che conteneva una parte della mia biancheria e un telaio di legno che mi era stato donato da mia madre e che a sua volta, aveva ereditato da mia nonna. Nella stessa camera da letto, dopo poco meno di anno dal mio matrimonio posizionammo con mio marita la culla, ‘a naca, che avrebbe ospitato il nostro primo figlio.
La naca, in parte paragonabile a una moderna amaca, era fatta con un sacco di iuta ai cui bordi venivano legate due corde e legata poi o al soffitto o, tramite qualche ingegnoso e manuale sistema, alle pareti nei pressi degli angoli.
Infatti dopo circa quattro mesi dal matrimonio, io ero in dolce attesa di Marco, il nostro primo figlio. Mia madre, le mie sorelle e le comari si dimostrarono subito premurose verso di me dandomi tanti consigli e suggerimenti.
Una sera di giugno, poco prima di andare a letto, iniziarono le doglie. Mio marito immediatamente corse a chiamare mia madre che subito, mentre veniva a casa nostra si fermò a chiamare ‘cummari Maria a levatrici.
E così nacque, con grande gioia di mamma e papà, Marco nostro primogenito che portava il nome di mio suocero.
Col passare degli anni tuttavia la mia famiglia aumentò di numero: infatti dopo Marco, arrivarono Giuseppe, Giovanna, Maria, Antonino e Carmela; altri cinque figli, a tavola eravamo otto.
Ricordo come fosse ieri che spesso, per tenere calmi i bambini, gli raccontavo, grazie anche all’aiuto di mia mamma o di mia suocera che venivano proprio a darmi man forte soprattutto quando dovevo andare al giardino, una vecchia storiella, una favola che raccontava a me la mia povera nonna: la favola di Giufà e loro, seduti fuori nel cortile o dentro nella stanza della cucina, ascoltavano attenti e incuriositi le avventure di questo simpatico e allo stesso tempo sciocco personaggio.
Storie e vicende di altri tempi, un diverso vissuto sociale differente da quello moderno! Uno spaccato sociale ricco di tanti valori umani, sociali, morali e civili dei quali la nostra identità sociale è ricca e ne deve andare orgogliosamente fiera.